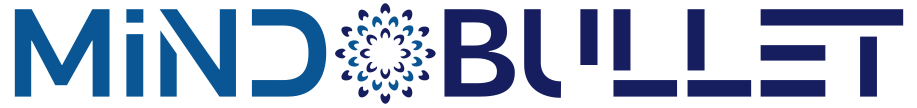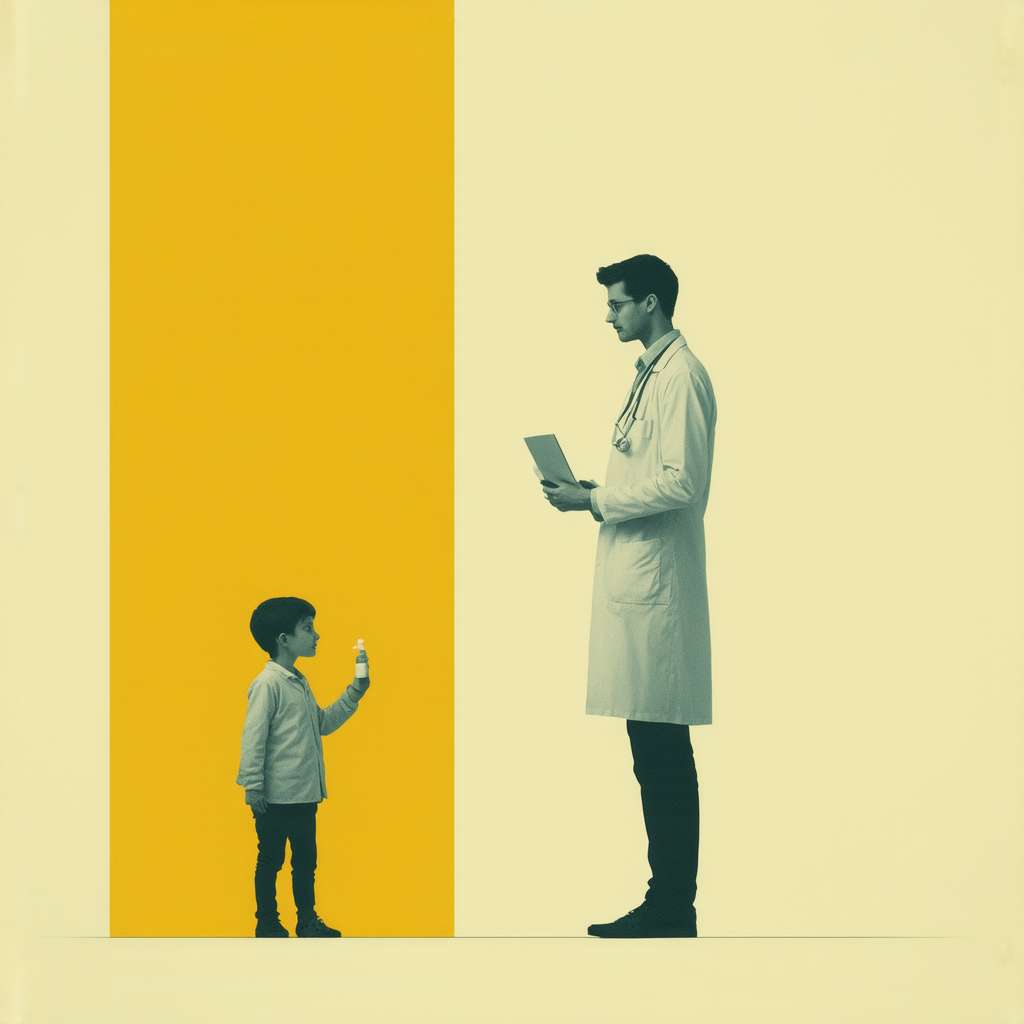E-Mail: [email protected]
- Il 56% dei serial killer italiani è nato nell'Italia settentrionale.
- Nel 44% dei casi, infanzia segnata da mancanza di affetto.
- Il 70% degli omicidi seriali avviene nell'Italia settentrionale.
L’ombra del serial killer in Italia: un’analisi complessa
Il “mostro di Firenze” ha distrutto l’idea che l’Italia fosse al sicuro dagli omicidi seriali. Prima degli anni ’80, si pensava che i crimini fossero causati solo da guadagno o da questioni sentimentali, escludendo la “gratificazione” come ragione. La mancanza di un termine italiano specifico ha favorito l’uso dell’espressione inglese “serial killer”. Le indagini spesso rispecchiano il caso Pacciani: oscurità, rifiuto iniziale del fenomeno, difficoltà a mettere in relazione i diversi omicidi, impreparazione delle forze dell’ordine e terrore diffuso. Questo modo di allontanare il problema rende più difficile l’individuazione e la prevenzione.
L’omicidio seriale in Italia è una realtà del XX secolo, con pochi episodi storici precedenti. Nel XIX secolo, Antonio Boggia uccise commercianti e imprenditori, mentre Callisto Grandi, “l’ammazzabambini”, scelse neonati come bersaglio. Un’analisi di 43 serial killer dal 1850 ad oggi mostra che la maggior parte è nata nell’Italia settentrionale (56%), con un’infanzia caratterizzata da mancanza di affetto (44%) o famiglie “divise” (35%). Il 14% ha passato anni in istituti per l’infanzia e il 21% aveva parenti con disturbi mentali. Quasi tutti avevano infranto la legge prima di commettere omicidi seriali. Eventi traumatici, sia fisici che psichici, precedono i delitti nel 40% dei casi, anche se non si può stabilire un legame di causa-effetto diretto.

Profili e modus operandi: uno sguardo ravvicinato
L’integrazione sociale del 63% dei serial killer è scarsa o assente. Il 26% è senza impiego, il 14% si dedica ad attività illecite, il 38% svolge mansioni di basso livello e una minoranza, soltanto il 7%, possiede una professione qualificata. Il 58% soffre di disturbi mentali. L’età media al momento del primo omicidio è di 30 anni, e sale a 34 per l’ultimo. Il 70% degli omicidi si concentra nell’Italia settentrionale. Le armi da fuoco sono le più utilizzate (37%), seguite da armi da taglio (16%), strangolamento (17%) e oggetti contundenti (12%). Il 70% degli assassini seriali italiani rientra nella categoria degli “organizzati”, il 20% in quella dei “disorganizzati” e il restante 10% mostra una pianificazione solo parziale. Il 10% intrattiene rapporti intimi con le vittime prima di toglierle la vita, e il 6% si abbandona a torture. Nel 60% dei casi, il corpo senza vita viene abbandonato sulla scena del crimine. Atteggiamenti macabri verso i cadaveri si verificano nel 30% degli omicidi. Solo l’1% si consegna spontaneamente alle autorità, e una simile percentuale tenta di togliersi la vita. La metà si dilegua dalla scena del crimine dopo aver rubato oggetti di valore o cancellato le prove.
Gli assassini seriali italiani inizialmente negano ogni coinvolgimento, per poi ammettere qualche dettaglio cercando delle scuse. Successivamente, messi alle strette dagli interrogatori, confessano dapprima alcuni delitti, e poi tutti. Nella maggioranza dei casi non mostrano segni di pentimento, rimanendo impassibili o arroganti. Solo il 2% esprime rimorso e il 14% afferma che ripeterebbe i suoi crimini. Musci, Scarso e Tavella definiscono “l’area della probabilità” come l’insieme dei delitti irrisolti caratterizzati da particolare brutalità che, per somiglianze, possono essere raggruppati in serie omicidiarie coerenti. Questa analisi permette di stimare il “tasso di probabilità serial killer” e di creare un identikit o un profilo psicologico. Il Piemonte è considerata “zona a rischio” a causa della tipologia delle vittime e della frequenza degli omicidi. Dal 1988 al 1996, diverse sequenze di delitti con prostitute come bersaglio si sono sovrapposte, interessando ampie aree della regione.
Casi emblematici: Stevanin e Bilancia
L’omicidio seriale in Italia è perpetrato prevalentemente da “lupi solitari”, che operano in contesti provinciali e in paesi di piccole dimensioni. Le vittime sono in maggioranza donne e bambini. Alcuni casi riguardano operatori sanitari che sopprimono pazienti anziani. Gli omicidi seriali di prostitute sono frequenti. I serial killer italiani mostrano la “sindrome dell’alienazione”, problemi relazionali e difficoltà ad adattarsi al mondo reale. In alcune situazioni, le vittime sono consorti, amanti o donne con le quali l’omicida aveva una relazione affettiva (“sindrome di Barbablù”). Sono rari i casi di donne serial killer. Gli omicidi seriali commessi da coppie sono un’eccezione, come nel caso di Wolfgang Abel e Mario Furlan, che si facevano chiamare “Ludwig” e uccidevano i “rifiuti della società”. La “banda della uno bianca”, composta da carabinieri, ha tolto la vita a 24 persone in sette anni, spesso per una soddisfazione sadica. Gli assassini seriali italiani sembrano esibire perversioni meno estreme rispetto a quelli di altre nazioni.
Gianfranco Stevanin, “il mostro di Terrazzo”, è stato catturato nel 1994 dopo che una prostituta austriaca è riuscita a scappare dalla sua automobile. Le ispezioni hanno portato alla luce riviste pornografiche, peli pubici e documenti appartenenti a donne scomparse. Stevanin è stato condannato a tre anni per violenza sessuale, sequestro di persona e tentato ricatto. In seguito, sono stati ritrovati i corpi di Biljana Pavlovic e Claudia Pulejo in un fossato nei pressi della sua abitazione. Stevanin ha “confessato” quattro omicidi, affermando che le ragazze erano decedute tra le sue braccia durante rapporti sessuali spinti o a causa di overdose. Ha inoltre raccontato di aver smembrato un cadavere per nasconderlo.
Donato Bilancia, ribattezzato “il mostro della Liguria”, ha ricevuto 13 ergastoli per 17 omicidi commessi tra il 1997 e il 1998. Cresciuto in un ambiente familiare problematico, ha avuto i primi problemi con la giustizia nel 1965 per furto. Negli anni ’80, ha iniziato a giocare d’azzardo e a commettere reati da solo. Il suicidio del fratello nel 1987 lo ha segnato profondamente. Nel 1997, ha preso la decisione di uccidere dopo aver sentito due biscazzieri prenderlo in giro. Ha ucciso Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti, poi ha continuato ad uccidere per depistare le indagini. Ha anche assassinato prostitute e viaggiatori sui treni. È stato arrestato nel 1998 grazie alla segnalazione di un amico che gli aveva venduto una Mercedes nera.
Oltre l’orrore: riflessioni sulla psiche criminale
I casi di Stevanin e Bilancia, pur nella loro singolarità, offrono una visione sconcertante della complessità della psiche umana e delle dinamiche che possono spingere un individuo a commettere atti di brutale violenza. La “sindrome dell’alienazione”, spesso presente in questi soggetti, mette in luce una profonda difficoltà nello stabilire relazioni significative e un senso di estraneità rispetto al mondo che li circonda.
Dal punto di vista della psicologia cognitiva, possiamo considerare come i bias cognitivi, ovvero distorsioni nel modo in cui elaboriamo le informazioni, possano giocare un ruolo cruciale. Ad esempio, il bias di conferma potrebbe portare un individuo a ricercare e interpretare le informazioni in modo da confermare le proprie convinzioni preesistenti, anche se queste sono irrazionali o dannose. Nel caso di un serial killer, questo potrebbe tradursi nella giustificazione dei propri atti attraverso una visione distorta della realtà.
Un concetto più avanzato è quello della teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire stati mentali (credenze, intenzioni, desideri) a sé stessi e agli altri. Una compromissione di questa capacità potrebbe rendere difficile per un individuo comprendere le conseguenze delle proprie azioni sugli altri, facilitando la commissione di atti violenti.
Riflettiamo, quindi, su come la comprensione di questi meccanismi psicologici possa aiutarci a sviluppare strategie di prevenzione e intervento più efficaci, non solo a livello individuale, ma anche a livello sociale, promuovendo una cultura dell’empatia e del rispetto per la dignità umana.